SOMMARIO
![]() Ferdinando Fuga: l'architetto della rinascita
Ferdinando Fuga: l'architetto della rinascita
![]() La Sicilia nel Vento del Sud
La Sicilia nel Vento del Sud
![]() pagina precedente
pagina precedente
![]()
Anno IV - Numero 1 - Gennaio 1999 - 139° dall'occupazione
edizione ridotta internet
SOMMARIO
![]() Ferdinando Fuga: l'architetto della rinascita
Ferdinando Fuga: l'architetto della rinascita
![]() La Sicilia nel Vento del Sud
La Sicilia nel Vento del Sud
![]() pagina precedente
pagina precedente
![]()
UNA STRAGE ORRENDA
Ottomila Napoletani morirono il 21, 22 e 23 gennaio 1799 per le strade, i vicoli e le piazze di Napoli, per difendere la città dall'aggressione delle truppe francesi. I Napoletani persero per il tradimento infame dei giacobini, che osarono sparare e bombardare alle spalle il loro popolo, che moriva per difendere l'orgoglio civile della città
Difendiamo la memoria gloriosa di Napoli
un tempo grande capitale europea
RICOSTRUIAMO L'ORGOGLIO NAPOLETANO
Col governo d'Alema è iniziata una fase nuova del secolare attacco dello Stato "italiano" contro il tessuto economico del Sud. Finora le cooperative "rosse" dell'Emilia Romagna avevano avute scarse possibilità di partecipare alla spartizione della torta. Ora, invece, con un presidente del consiglio pidiessino, si apre una stagione di conquista forsennata del mercato meridionale, anche da parte delle Coop.
Una delle primissime risoluzioni del nuovo governo è stata, infatti, quella di preannunziare l’apertura al Sud, con i soliti contributi statali, di una raffica di faraonici stabilimenti emiliani.
Siamo veramente all’epilogo della tragicommedia italiana: l’Emilia Romagna, che prima del 1860 era la regione piú povera d’Italia, viene ora ad imporre la sua legge in quel Sud, che, sfruttato all’osso dai criminali governi sabaudi postunitari, consentí a suo tempo le bonifiche e il decollo economico delle terre emiliane!
Attendiamoci, dunque, l’apertura di questi nuovi formidabili canali per la penetrazione delle merci padane al Sud. Prima lo Stato concedeva ai meridionali almeno la funzione di intermediari nella vendita dei prodotti del Nord. Ora, invece, si vuole consentire ai padani di esercitare al Sud finanche la commercializzazione dei loro prodotti. Questo nuovo fenomeno èdestinato a colpire ulteriormente la già precaria produzione meridionale e a disarticolare ulteriormente il piccolo commercio e l’artigianato, con contraccolpi che si faranno sentire anche al Nord: le ondate migratorie verso la Padania e l’arco alpino vi troveranno una nuova, ennesima, fonte di alimento.
Se da una parte il nuovo governo continua, con modalità sempre piú efficaci, la secolare politica di svuotamento economico del Sud, dall’altra tenta, con l’assunzione di Bassolino alla carica di ministro, la stessa operazione di immagine che questi ha operato per Napoli.
Per tale via la sinistra italiana spera di darsi una credibilità meridionalista, ma il nuovo governo, oltre che tenere in piedi la vecchia pratica assistenzialista, non potrà fare nulla per affrontare l’eterna emergenza sociale che attanaglia il Sud. Per incidere seriamente a favore del Sud occorre uscire radicalmente fuori dagli schemi mentali imposti dal sistema, ponendo la necessità di affrontare i problemi del Sud senza il condizionamento delle leggi di mercato, che dall’"unità" d’Italia militano necessariamente a favore dell’economia padana a discapito di quella meridionale.
Il Sud, per rinascere economicamente, ha bisogno del fattore decisivo che ha costituito la fortuna della pianura padana, ha bisogno cioè della protezione incondizionata di un suo Stato.
La sinistra italiana, invece, esattamente come la destra, ritiene che tutto debba essere risolto mediante direttive che provengano dai tavoli romani o bolognesi, rinnovando l’infame patto unitarista, fondato sulla vuota retorica del tricolore e sulla conservazione di quel meccanismo perverso che accomuna gli affari dell’economia padana e la corrispondente disoccupazione meridionale in una medesima dinamica.
Il Sud non ha, dunque, diritto di proteggere la propria economia, come avviene in un qualsiasi territorio del mondo, altrimenti si minerebbe la tenuta falsamente unitarista dello Stato "italiano": questo è il vero nodo della "questione meridionale".
Il patto di ferro tra affari padani e partiti tricoloristi non concede tregua al Sud, cui è consentito di sopravvivere solo come appendice al Nord. Al Nord spetta il compito di dar da mangiare ai meridionali, ma questi in cambio non devono pretendere alcun diritto. Solo al Nord spetta di produrre, mentre ai meridionali è assegnata l’eterna condizione dei mendicanti.
Quanto al lavoro o i meridionali si trasferiscono al Nord o si devono dar da fare, tramite i loro "rappresentanti", affinché le aziende del Nord aprano filiali al Sud. Questa negazione completa di ogni diritto alla dignità civile dei meridionali è la vera radice dell’infernale sbandamento morale e civile che dal 1860 dilaga liberamente al Sud.
È tempo per i meridionali degni di questo nome di organizzarsi e di rifondare il loro onore, ed il loro sacrosanto diritto di esistere al cospetto delle nazioni civili. Questa battaglia enorme ed entusiasmante di resurrezione storica e civile di un intero popolo non può essere condotta solo dai meridionali residenti al Sud: è necessario il concorso potente di tutti i meridionali della diaspora, di tutti i meridionali sparsi nel mondo che non hanno voltato le spalle alle loro origini. Che questo appello possa viaggiare ovunque, grazie all’edizione Nord di Nazione Napoletana, l’unico giornale sudista diffuso all’estero.
Edoardo Spagnuolo
![]()
FERDINANDO FUGA : l'architetto della rinascita
La storia spesso, nella sua accezione piú frequente, emana una sorta di staticità plumbea, una rigidità ferrea tale da sconfortare e scoraggiare soprattutto il giovane che ad essa faticosamente si appressa. Questo per delineare un modo corrente di considerare la storia da cui, probabilmente, non è immune anche Nazione Napoletana. Ovviamente la storia è dinamica esclusivamente quando si compie nel presente: tuttavia esiste, a mio modo di vedere, un modo dinamico di servirsi e di accostarsi alla storia, ovvero di poter dinamicamente accedere alla storia per meglio servirsene. Solo in questo senso la storia è maestra di vita; solo se riattualizzata, dopo il necessario processo di emendazione, di confronto delle fonti, di abolizione dei pregiudizi, la storia può rivivere in altri luoghi, in altri tempi, come il vero fondamento delle civiltà. Ma questo discorso, per quanto affascinante, rischia di portarmi lontano da quello di cui voglio scrivervi, se pure ad esso è propedeutico.
Oggetto di questo articolo è un libro regalatomi da un amico architetto dal titolo "Ferdinando Fuga a Napoli", edizioni del Grifo, autore Paolo Giordano.
Il libro al di là delle disquisizioni tecniche di rilievo apprezzabili solo dagli addetti ai lavori, offre spunti per diverse riflessioni non solo in riferimento all’architettura. Già esteticamente esso si fa apprezzare per il formato, la ottima qualità della carta e la bella foto di copertina che ritrae il "Cimitero delle 366 fosse"; poi all’interno, in epigrafe al testo, una significativa frase del grande architetto tedesco Mies van der Rohe che qui riportiamo: "la vera architettura è sempre oggettiva ed è l’espressione dell’intima struttura dell’epoca nel cui contesto si sviluppa".
Ora se non m’inganno l’architettura è oggettiva non solo perché si mostra realmente ai sensi in quanto forma, materia plasmata, ma è tale anche e soprattutto, per i contenuti "filosofici", "sociologici", in un termine "culturali", per cui quella forma ha un senso, un significato.
In tal guisa ripercorrere la storia delle architetture può assumere anche il valore di una rivisitazione sostanziale delle culture, delle società, delle politiche di remote nazioni e di defunte civiltà. Cosí, in un certo punto della premessa, l’autore dopo aver notato da un lato il naufragio della cultura del moderno in un acritico funzionalismo ingenuo e, dall’altra parte, l’esigenza di un progetto culturale consapevole dell’ineliminabilità della memoria storica, scrive: "troppo spesso si è allontanata (la cultura architettonica, N.d.R.) da una corretta utilizzazione delle testimonianze del passato. In tal senso la storia, intesa quale nuovo portato concettuale caratterizzante l’attuale dibattito, può essere riletta in modo diverso: utilizzando il disegno come linguaggio universale idoneo a svelare la vera essenza dell’architettura, sia di quella "costruita", sia di quella "non costruita"".
Partire, dunque, non solo dai segni, dalle forme e dalla materia che le costituisce, bensí attraverso di essi risalire per mezzo del disegno, quando l’opera non è realizzata, alla ideazione, alle emergenze politiche, sociali e culturali che le commissionarono, quindi in ultima analisi, alla rilettura di un presente che adesso chiamiamo storia.
Da questa articolazione non statica dei processi storici, se pur non esplicitamente citati nel libro, si possono dedurre conclusioni (ma si potranno mai avere conclusioni sull’arte?) che esporrò solo dopo alcune doverose precisazioni su Ferdinando Fuga e le sue opere descritte nel testo.
Ferdinando Fuga (Firenze 1699 - Napoli 1782) giunse alla corte di Carlo di Borbone nel 1748, insieme al piú noto architetto Luigi Vanvitelli, chiamato dal giovane sovrano a partecipare alla ricostruzione non solo civile della capitale, "ereditata" dopo trenta anni di ruberie austriache. Le esperienze maturate a Roma nel ventennio tra il 1730 ed il 1750 convinsero Carlo di Borbone ad avvalersi della collaborazione del Fuga nel delineare l’ambizioso progetto di ridisegnare un nuovo assetto urbanistico di quella che nel libro si definisce "città del futuro".

Mentre da un lato Vanvitelli si occupa di quella che sarà poi la Reggia di Caserta, il Fuga si impegna in un ambizioso progetto commissionato direttamente dal Re. Inizia a disegnare l’Albergo dei Poveri, (vedi foto in questa pagina) noto a Napoli con il nome "’O Serraglio", un mastodontico edificio la cui mole è senza precedenti non solo in Italia. I viaggiatori del Gran Tour che giungeranno a Napoli da Roma all’inizio dell’Ottocento, resteranno vivamente impressionati non solo da tanta imponenza, ma soprattutto dal grande equilibrio delle forme, dalla decisione dei tratti.
Sempre nel quadro dell’opera di ordinare lo sviluppo della città al di fuori delle mura, partendo da impianti di impatto "sociale", il Fuga progetta nel 1762 il Cimitero delle 366 fosse sulla collina di Poggioreale. Va ricordato che in precedenza i morti venivano sepolti fuori le mura senza alcun ordine o nella fossa dell’Ospedale degli Incurabili.
Intanto Carlo di Borbone è già Re di Spagna da due anni, lasciando il Regno delle Due Sicilie al figlio Ferdinando IV sotto la tutela del Tanucci. Ma, come a tener fede ad un impegno precedentemente assunto, anche sotto il nuovo monarca continua la cosiddetta "architettura sociale" del maestro fiorentino. È del 1779 il progetto dei cosiddetti "Granili", demoliti dopo la seconda guerra mondiale. I Granili sorgevano sulla spiaggia della "Maddalena", tangenzialmente alla strada che conduceva al famoso "Miglio d’Oro" delle ville vesuviane.
L’imponenza della costruzione è bene evidenziata da alcune foto presenti nel libro. Contrariamente a quanto è immediatamente deducibile dal nome dell’edificio, in esso trovavano ospitalità gli arsenali di artiglieria e fabbriche di cordami, oltre che, naturalmente, i granai pubblici.
È decisiva la rilettura che di tali opere effettua il prof. Giordano poiché restituisce alle architetture il loro originario valore non solo simbolico, ma ribadisce la loro connessione diretta sia con il committente che con la sua politica di rinascita, perciò, per nulla affidata al caso, anzi concepita con lucidità in ogni suo aspetto, e non invece come scrive il Ghirelli nella sua "Storia di Napoli" (Einaudi), in riferimento alle architetture del Fuga, "inseriti (gli edifici) nel paesaggio con un procedimento astratto che non tiene conto della tradizione culturale dell’ambiente e tanto meno delle sue esperienze urbanistiche".
In realtà gli edifici rappresentavano i nuovi cardini su cui si doveva sviluppare la città fuori le mura, i punti fermi di un ordito urbano razionale, pianificabile e permutabile all’occorrenza, in funzione delle emergenze socioculturali.
In sintesi l’inizio di un progetto di città moderna, funzionale e pure rispettosa di quella tradizione ambientale troppo spesso citata, ma non sempre significativamente. Va ricordato soprattutto ad uso dei denigratori mestieranti dei Borbone (i quali non mancarono di rimarcare che le opere magnifiche di cui la dinastia si fece commissionaria furono semplice diversivo per deviare le critiche per la costruzione della Reggia di Caserta e che i soldi spesi per la costruzione dell’Albergo dei Poveri si potevano diversamente impiegare) che la tendenza a dimostrare la potenza di una nazione attraverso lo sfarzo e la maestosità delle fabbriche era generalizzato in Europa e se è vero che a ciò non si sottrassero i regnanti napoletani, è pur vero che, al contrario dei piú democratici e liberali governi tanto osannati dagli intellettuali partenopei, almeno tentarono un approccio al problema dei poveri che, a Londra e Parigi, morivano ignorati in mezzo alle strade.
F.C.
![]()
LA BATTAGLIA DEL MACERONE
Questa volta il nostro inviato speciale RIN, è stato incaricato di fare un "reportage" sulla battaglia del Macerone, anche questa del tutto sconosciuta, perché volutamente cancellata dalla storiografia ufficiale fabbricata dai conquistatori piemontesi. Generalmente, quando si cancella o si modifica un avvenimento, è perché se ne ha vergogna. Ed anche in questo caso la parola "vergogna" esprime molto poco. In questi avvenimenti si trova di tutto: menzogne, tradimenti, assassinii, vigliaccheria, ladrocini e fucilazioni, tante fucilazioni. Di questi putridi disvalori, senza possibilità di smentite, si nutre la gloria dei Savoia e dei loro lanzichenecchi, del Risorgimento, dell’unità d’Italia. È terribile rendersi conto di queste verità incontrovertibili, ma è ancora piú terribile rendersi conto che ancora oggi questi avvenimenti vengono nascosti e mistificati. Il motivo non può che essere uno solo: il Sud è ancora una colonia e i suoi popoli non devono mai conoscere la verità.
Antonio Pagano
LA STRADA CONSOLARE PESCARA - NAPOLI
Nel 1860 una magnifica strada consolare, vanto della tecnologia pontiera napolitana, collegava l’allora villaggio di Pescara con Sulmona e, quindi, con Napoli. Di quella strada, oggi coperta d’asfalto, unico omaggio al progresso, rimangono tuttora, a margine della banchina, le antiche gigantesche pietre miliari che gli abitanti della zona ammirano stupiti e "dello ‘mperché non sanno". Non sanno che cosa significano quei numeri misteriosi per esempio 118, 119, 120, 121 e cosí via, un tempo esprimenti la distanza militare da Napoli, incisi sui tútuli che dal bivio di Corfinio verso Popoli, e su per la cosiddetta "Strada delle Svolte", luogo di agostano rally di montagna, fino all’Aquila, si ripetono a regolare distanza.
La strada, poi, lasciata Sulmona in direzione Napoli, si inerpicava, come oggi la statale n. 17, fino a Rivisondoli, Roccaraso e Castel di Sangro, dopodiché tra panorami verdissimi e silenti iniziava sul versante tirrenico, parte nella valle del fiume Volturno, parte nella valle dei fiumi Sordo e Cavaliere, la discesa per Isernia fino a Venafro e alla Città caput Regni.
Nel maledetto 1860 quella strada consolare fu teatro di guerra dei piú significativi dal punto di vista strategico. Parlare di tale strada significa pure parlare della situazione degli Abruzzi prima che vi penetrassero i ladroni e gli assassini savoiardi-piemontesi.
A Pescara un’austera fortezza a forma pentagonale, comandata dal colonnello Piccolo, fungeva da retroguardia alla piú famosa Civitella del Tronto ed al forte di Aquila. Garibaldi, coadiuvato da una miriade di traditori nostrani, in primis quel tanghero rinnegato di Liborio Romano, il 7 settembre era entrato in Napoli col treno da Salerno. Nella nostra capitale, il novello napoleonide, per manifestare il suo gradimento per il luogo, ma anche la sua educazione civica, come pure il suo disprezzo per il popolo Napolitano, appena sbarcato si faceva una volgarissima pisciata accanto al treno, il che nel linguaggio animale ha il mero significato di presa di possesso di un territorio. Mentre il Real Governo delle Due Sicilie, stabilitosi a Gaeta, controllava ancora parte del territorio della Terra di Lavoro, i tre Abruzzi ed il Molise, da Ancona, due corpi d’armata savoiardi, il IV ed il V, comandati rispettivamente da Enrico Cialdini ed Enrico Morozzo della Rocca, si muovevano per terra e per mare per dare al Reame il colpo di grazia alle spalle, una pugnalata, in perfetto stile sabaudo, di cui faranno mala esperienza pure i francesi, ottant’anni dopo, nel 1940.
L’ARRIVO DEI TARTARI
46 battaglioni di 39.000 baionette si misero, dunque, in movimento. Capo di Stato Maggiore il generale Manfredo Fanti a fianco del tozzo re del Piemonte, giunto ad Ancona il 3 ottobre per assumere il comando del corpo di spedizione. "La presenza di costui dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, che l’invasione del Regno delle Due Sicilie era stata già decisa da molto tempo" (Antonio Procacci: Storia Militare dell’Abruzzo Borbonico, Brionj Roman Style editore, 1990). Tali corpi d’armata erano fiancheggiati da tre colonne mobili, ognuna di circa 2.500 individui.
La prima, la brigata Bologna, comandata dal famigerato boia Pinelli, "destinata negli Abruzzi per reprimervi eventuali moti reazionari e facilitare l’avanzata del corpo di operazioni principale" (col. C. Cesari, L’assedio di Gaeta), lavoro che fece coscienziosamente in perfetto stile giacobino-nazista mettendo a ferro e fuoco tutto l’Abruzzo Ultra 2° e fucilando in massa a Pízzoli, Scúrcola Marsicana, Fiamignàno, Borgocolefègato (oggi Borgorose), Pescorocchiàno, Petrèlla, cioè tutta l’antica provincia di L’Aquila, comprendente, rispetto a quella odierna mutilata nel 1923, i territori annessi al Lazio nel 1923 per disposizione di Mussolini, vale a dire il Cicolano e i territori di Borbona, Cittaducale, Antrodoco, Leonessa, Amatrice, Accúmoli, compresi nella valle del fiume Velino fino alle sorgenti del Tronto.
La seconda colonna mobile, comandata dal generale Brignone, doveva dirigersi verso l’Aquila e convergere su Popoli per unirsi al V corpo d’armata.
Una terza, comandata da De Sonnaz, via mare, doveva sbarcare a Manfredonia, indi via Foggia, Bovino, Ariano, Benevento, Arienzo, doveva portarsi verso Capua (Piedimonte) sul Volturno e collegarsi quindi alle forze provenienti da Napoli in modo da stritolare in una tenaglia il residuo esercito delle Due Sicilie.
Il corpo principale degli invasori avrebbe seguito la litoranea da Ancona a Pescara. Ma la litoranea era sbarrata dalla poderosa fortezza di Pescara, che verrà distrutta dai beceri sabaudi al pari di quella di Civitella del Tronto (quella visibile oggi è quasi tutta una ricostruzione promossa dalla Regione Abruzzo, mentre di quella di Pescara non si trova piú neppure un mattone).
LA FORTEZZA DI PESCARA
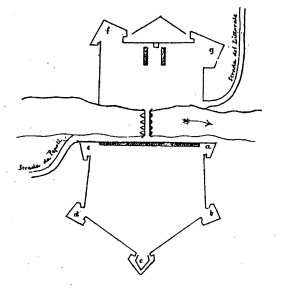
La fortezza di Pescara, il suo armamento, la consistenza del numero dei difensori era noto ai nemici fin nei minimi particolari, come risulta dalla dettagliata descrizione del diario del V corpo d’armata. Considerato che la fortezza non è piú esistente, vediamo come brevemente la descrive il generale napolitano Giovanni Delli Franci (Cronica della campagna d’autunno del 1860, A. Trani ed., Napoli, 1870, pag. 162), in modo che il lettore se ne possa fare un’idea la piú approssimata possibile: "Questa piazza noverata tra quelle di seconda classe è chiusa da un pentagono a cavallo della strada consolare e del fiume. Le fortificazioni sulla riva dritta sono bastioni e cortine protette da quattro tanaglie, fossati e strade coperte, con traverse, piazze d’armi e spalti. Sulla sinistra si distende una opera a corno, in cui è un alloggiamento per cavalleria ed una piazza d’armeggiamenti".
Le piazze e i forti erano divisi in quattro classi. Le piazze di Pescara e di Civitella del Tronto erano considerate di seconda classe, mentre il forte dell’Aquila di quarta. La guarnigione di Pescara comprendeva normalmente un battaglione di fanteria e una compagnia di artiglieria (circa 2000 uomini). Nelle tre province abruzzesi si reclutavano, per la fanteria, il 6° reggimento di linea "Farnese" ed il 10° reggimento di linea "Abruzzo" piú il 6° ed il 10° battaglione Cacciatori per i quali erano a disposizione due ospedali militari, uno a Chieti con 112 posti e uno a Pescara con 98 posti (Rivista militare italiana, n. 5/87 in A. Procacci, Storia Militare dell’Abruzzo Borbonico).
TRADIMENTO
A metà settembre 1860 improvvisamente in Gaeta, sede provvisoria del Governo delle Due Sicilie, viene emesso il seguente: "Ordine del Ministro della Guerra - Il brigadiere Luigi de Benedictis, viene sottoposto al competente Consiglio di Guerra, per la condotta tenuta nel suo comando territoriale dei tre Abruzzi. Gaeta 15 settembre 1860. - Firmato : Casella"
Per meglio intendere lo scarno linguaggio, tipicamente militare, di quell’ordine del Ministro della Guerra Ten. Gen. Francesco Casella, che deferiva al Consiglio di Guerra il numero uno dei preposti alla difesa del Regno dalla parte degli Abruzzi, bisogna considerare l’organigramma militare della regione in quell’infelicissimo settembre 1860: al vertice della gerarchia militare dei tre Abruzzi era il brigadiere generale Luigi de Benedictis; alle sue dipendenze, quale comandante dell’Abruzzo Citra (Chieti), il colonnello Scavo; quale comandante dell’Abruzzo Ultra Primo (Teramo), il generale Veltri; quale comandante dell’Abruzzo Ultra Secondo (l’Aquila), il colonnello Perez.
In sostanza il generale de Benedictis, con un passato militare "per intelligenza, per sapere e per energia, commendevole" (Delli Franci, pag. 158) e succeduto al generale Pianell, quando questi era diventato Ministro della Guerra, doveva essere sottoposto al tribunale di guerra per alto tradimento. Eppure fino a una settimana prima il generale Duca di Sangro, maresciallo di campo, aiutante generale del Re Francesco II, gli aveva telegrafato: "Gaeta 7 settembre 1860 - ore 10.00 p.m. - S. M. il Re (D.G.) è contentissimo del buon ordine e dello spirito pubblico degli Abruzzi; raccomanda di conservarlo, mettendosi di accordo con le autorità locali, sí civili, che militari. Ella diriga i suoi rapporti a S.M. il Re (N.S.) in Gaeta e tutte le altre autorità facciano altrettanto - Firmato: di Sangro".
Lo stesso aveva fatto in pari data con altro telegramma il ministro della guerra Casella: "Casella a de Benedictis - Gaeta 7 settembre 1860 - La sede del Governo è in Gaeta. Mantenete l’ordine nelle tre province. Dirigete qui i vostri rapporti. - Firmato: Casella".
La nuova sede del Governo delle Due Sicilie a Gaeta era stata comunicata anche alle cancellerie europee dal Ministro degli Esteri De Martino il giorno prima.
Contemporaneamente l’infame doppiogiochista Liborio Romano avvertiva con altro telegramma l’avventuriero Garibaldi in Salerno, che il giorno dopo faceva il suo ingresso nella Capitale.
LA VIA AL TRADIMENTO
Che cosa era successo nel breve lasso di tempo di appena otto giorni? Si era scoperto il vero volto di quel criminale traditore della Patria. Infatti "quando le cose precipitavano, concepí lo sciagurato, sebbene arduo, pensiero di consegnare i luoghi forti al nemico ... e di far sicura la strada all’esercito sardo, che vedemmo poscia invadere senza cartello (cioè senza dichiarazione di guerra, N.d.R.) quelle province". Nel mese di agosto 1860, "aggiungendo con arte insidiosa i suoi commenti agli ordini che emanava da Napoli il ministro della guerra Pianell, prescrisse a tutte le autorità delle tre province un regolamento per la interna sicurezza, che disse confacente alle condizioni del Reame in quel tempo, e ne comandò l’esatta osservanza", annota il generale dello Stato Maggiore dell’Esercito Napolitano Giovanni Delli Franci nel libro citato (pag. 158). Ma poi: "Si era al dí otto settembre; il Re aveva lasciato Napoli; l’esercito stava ragunato nella Valle del Volturno ed il de Benedictis conscio di tali avvenimenti, si avvisò di dissolvere i difensori del Castello di Aquila (di cui era comandante il capitano Capaldo, alle dipendenze del colonnello Perez, uomo di "poco senno", comandante della provincia di Aquila, N.d.R.). Per attuare il suo concetto, per telegrafo significò al Perez che il Re nell’uscire da Napoli aveva ordinato a tutti i militari di non fare ulteriore resistenza e di conservare la disciplina, obbedendo alle autorità costituite" (Delli Franci, pag. 160). Ecco il messaggio al colonnello Perez: "Quanto prima io verrò costà; fate leggere alla truppa del presidio le seguenti parole: Nel partire da Napoli S.M. il Re Francesco II ordinò a tutti i militari che non avessero fatto piú veruna resistenza, che avessero conservata la disciplina e che avessero in tutto obbedito alle autorità costituite. Ecco il mandato che noi abbiamo e dobbiamo eseguire, se vogliamo essere militari onorati e non nemici della patria. - Firmato de Benedictis". Continua il Delli Franci, eroico combattente del Volturno e di Gaeta: "Poscia nelle ore vespertine del medesimo giorno si recò di persona in Aquila; riuní tutti gli uffiziali a casa sua, non esclusi quelli dell’officio topografico che ivi erano di passaggio; lesse loro gli ordini del dittatore (Garibaldi, ndr) che invitavali di aderire al nuovo governo, conservando i gradi e le loro paghe, e persuase tutti a mutar bandiera".
Quali erano, secondo il tristanzuolo stratega, le autorità costituite? Leggiamo insieme il proclama che indirizzò al presidio del castello di Aquila in data 10 settembre 1860, dopo che ebbe convertito al nuovo ordine gli ufficiali del castello, eccetto il capitano dei cacciatori Giordano: "Bravi artiglieri e zappatori - Una fronda dall’albero non cade se non per la volontà di Dio, a cui noi tutti dobbiamo umilmente rassegnarci. Il nostro Re Francesco II, se n’è andato e ciò deve ritenersi ancora essere avvenuto per volontà di Dio. Nell’andarsene, altro mandato non ha rimasto (sic!), che conservare la disciplina e la ubbidienza alle autorità costituite. Soldati - il nuovo governo di Vittorio Emanuele, per mezzo del dittatore Garibaldi, ci fa sapere, che chi vuole rimanere al servizio, rimanga, e chi vuole andarsene, se ne vada; tanto per coloro che hanno compito l’impegno, come pure per chi non l’ha compito. Resti ciascuno libero di servire ed infine vi si raccomanda di rispettare le leggi, perché solo cosí sarete bravi cittadini, come foste ottimi soldati" (Delli Franci, pag. 294, nota 120).
In pari data, il 10 settembre, il traditore invia alla guarnigione di Pescara, comandata dal suo complice colonnello Piccolo, una ingannevole nota con lo scopo di far sbandare la guarnigione: "Il Re è uscito dal Regno, tutto è finito; consiglio la guarnigione a regolarsi secondo la prescrizione del ministro della guerra di Garibaldi" (Delli Franci, pag. 300, nota nr. 128).
Quel giorno la fortezza era presidiata da circa 2.000 uomini, per la precisione da sette compagnie del 12° Cacciatori, comandate dal maggiore Pirella, che tuttavia in seguito raggiungerà il Re a Gaeta con i suoi uomini; da una batteria di artiglieria da campagna, comandata dal capitano Dupuy; da quattro compagnie di Zappatori, comandate dal capitano D’Escamard; dall’artiglieria di piazza, comandata dal Ten. Col. Gaudiani. I pezzi di artiglieria erano in totale 81, di cui 61 già pronti al fuoco (S.M.E. - Uff. Storico, G.56/32 in A. Procacci, pag. 380). Senza questo tradimento, forse quegli uomini avrebbero potuto dare un corso diverso alla storia.
Il venduto colonnello Piccolo, nel frattempo, si era attivato per neutralizzare la guarnigione e mettersi al servizio dei nuovi padroni fin dal giorno 8 settembre, quando, via telegrafo, gli erano pervenute direttamente da Napoli le disposizioni del governo dittatoriale di Garibaldi, tramite un altro rinnegato, il generale Cosenz, disposizioni che trascriviamo:
"Il ministro della guerra Cosenz a tutti i comandanti le armi nelle province ed a tutti i comandanti, o governatori delle piazze. - Questo ministero di guerra manifesta agli uffiziali di ogni grado ed ai militari dell’esercito napolitano, essere volere del signor generale dittatore, che tutti siano conservati nella loro integrità, sí nei gradi, che negli averi: però si avranno le seguenti norme: 1°) Tutti i militari dell’esercito che bramano servire, si presenteranno ai comandanti, o governatori delle piazze dei luoghi piú prossimi al loro domicilio, rilasciando ad essi debito atto di adesione all’attuale governo ed il loro ricapito. - 2°) Gli uffiziali che si presenteranno con le truppe saranno conservati nella loro posizione con gli averi di piena attività, ma quelli che si presenteranno isolatamente, saranno segnati alla seconda classe, per essere poscia opportunamente impiegati nella imminente composizione dell’armata. - 3°) Quegli uffiziali militari, che non si affrettino di presentarsi al servizio della patria, resteranno di fatto esclusi e destituiti, se non faranno atto di adesione nella maniera indicata, tra dieci giorni, a contare dalla pubblicazione della presente disposizione. - Tanto le comunico per lo esatto adempimento di sua parte. - Napoli 8 settembre 1860 - Firmato: Cosenz" (Delli Franci, pag. 297).
Le quali disposizioni aveva contemporaneamente ricevuto anche il de Benedictis. Il colonnello Piccolo "contro l’avviso del consiglio di difesa ... fece prima divulgare le ingiunzioni dittatoriali", ma "i soldati tumultuarono; gittarono in aria ciò che loro si leggeva, e proruppero concordemente nelle grida di "Viva ‘o Rre", mentre la fanfara dei Cacciatori spontaneamente intuonava l’inno Borbonico ... il castellano ... minacciato per forma ... dovette fuggire dallo sguardo dei suoi dipendenti ... Si pensò allora dalle ribelli autorità di ricorrere ad altro espediente, per intimidire i difensori della fortezza. Ed il giorno dodici settembre tutta la guardia cittadina, uscí dalla piazza con le armi e si fece propagare la voce, che sarebbesi unita all’altra dei circostanti paesi ed allo esercito garibaldesco, per assalire e combattere i difensori di essa ... E quando si seppe l’altra manifestazione del de Benedictis, che lasciava a tutti facoltà di scegliere tra il militare servizio ed il ritornare in patria; e soprattutto quando si videro i drappelli di soldati provenienti da Aquila, che avvaloravano con la loro presenza la verità delle licenze concedute dal de Benedictis, fu unanime la risoluzione di abbandonare la piazza. Onde il giorno sedici settembre, la soldatesca, lasciate le armi, si sciolse e la piazza fu custodita dalla guardia cittadina, che rientrò in paese per invito fattogliene dallo stesso Piccolo, che ne restò castellano, a nome del governo dittatoriale.
Gli uffiziali delle armi speciali ed altri dodici dei cacciatori col Pirella e col Ditta e dugento uomini inermi, furono i primi a presentarsi in Capua ed in Gaeta. Poscia a poco a poco la maggior parte del presidio di Pescara e di Aquila, si congiunse pure al corpo di esercito operante sul Volturno" (Delli Franci, pag. 164/165).
Dopo febbrili trame con i traditori della guardia nazionale, la sera del 15 settembre lo spregevole colonnello Piccolo consegna la piazzaforte agli annessionisti filosabaudi. Cosí i poveri fanti che non vollero abbandonare il loro posto di difensori della Patria, a piedi per monti e per valli, tra boschi e burroni, per balze e precipizi, attraverso fiumi e torrenti, soffrendo fame e freddo, in settembre già pungentissimo in quella Siberia delle Due Sicilie che sono gli Abruzzi, si diressero alla volta di Capua e di Gaeta, spinti da un unico imperativo categorico: vendetta.
Lo stesso contegno il traditore de Benedictis tenne col comandante della provincia di Teramo, il generale Veltri "vecchio settario" e col comandante della provincia di Chieti, il colonnello Scavo, "uomo di niuna fama", mentre nella piazzaforte di Pescara sin dal mese di agosto aveva già piazzato un suo uomo di fiducia, il già citato colonnello Piccolo che "favoriva anch’egli la rivoluzione, ma era piú circospetto nelle sue opere" (Delli Franci, pag. 162).
DAL NORD L’INIZIO DELL’INVASIONE
Dunque, per l’alto tradimento del vermone de Benedictis, gli Abruzzi ristettero indifesi e in mano a una triade di scellerati ladroni di nome De Virgili, de Cesaris e Delfico, che avevano inviato altresí una deputazione di 40 liberali a Vittorio Emanuele in Ancona perché entrasse nel Regno. E infatti il 12 di ottobre 1860, data che ogni duosiciliano dovrebbe sempre maledire, in cui vestirsi a lutto, l’armata lanzichenecca attraversò il Tronto e pose campo a Giulianova, lasciandosi alle spalle la fortezza di Civitella, innocua per un eventuale attacco alle spalle degli invasori. L’invasione fino alla foce del Pescara avvenne lungo la litoranea, il 14 gli aggressori presero la strada per l’interno. All’altezza di Chieti, il V corpo d’armata seguí la valle del fiume Pescara per Sulmona e Rocca Raso. Lungo la strada si ergevano minacciose le Gole dei Popoli, meno famose delle forche caudine, ma altrettanto insidiose e toste.
Se in quelle gole ripide, selvose, strettissime, percorse dal fiume Pescara, ingrossato al centro del canyon dal fiume Tirino, gonfio di spuma e turbinoso, ci fosse stato almeno un cannone e un centinaio di fucilieri, sarebbe stato fatto scempio di quei barbari invasori. Invece il nemico poté vantarsi di cantare come l’Ulisse omerico "Là distrussi la Città e sterminai gli abitanti".
Il IV corpo d’armata, invece, prese la strada per Chieti, Bucchiànico, Guardiagrele, Càsoli, Lama de’ Peligni, Rocca Raso. Anche il IV corpo dell’armata nemica avrebbe potuto essere distrutto nella strettissima e ripidissima valle che da Lama conduce a Palena e al Passo della Forchetta, a pochi km da Rivisondoli. È fin troppo evidente che, se nello Stato Maggiore Napolitano non fosse stato contaminato da tanti traditori settari, quelle valli sarebbero state sicuramente munite di forti e trincee.
IL TERRORE SAVOIARDO
A Rocca Valle Oscura, dal 1865 denominata Rocca Pia, l’unno-savoiardo cominciò, già durante l’invasione, a mostrare la sua ferocia contro molti poveri montanari che furono immediatamente fucilati su istanza di un criminale possidente del luogo, un certo Costantini, bramoso di vendetta per i moti di reazione avvenuti nelle località di Scontrone (R. De Cesare, La fine di un Regno). Era l’inizio del terrore savoiardo, rabbioso, violento, furibondo, grondante sangue, sterminatore, affamatore, predatore e distruttore dei beni della Nazione Napolitana. Cominciò il crepitío dei moschetti e il becero carnevale delle teste mozze dei nostri poveri contadini all’ingresso dei paesi.
Fucilazione, fucilazione, ancora fucilazione dei nostri sventuratissimi padri, finché non ne furono sterminati quasi un milione e la nostra dolce terra mediterranea non divenne un padúle verminoso di cadaveri. In soli dieci mesi, dal gennaio all’ottobre del 1861, si contavano nell’ex Regno delle Due Sicilie, secondo la stampa estera, 9.860 fucilati, decine e decine di migliaia uccisi in battaglia, 10.604 feriti, 918 case arse, 6 paesi bruciati, 13.629 imprigionati, 1.428 comuni in armi (Alianello).
Altro ed altissimo invece il grido d’orrore di La Civiltà Cattolica: in pochi mesi i morti avrebbero già superato il numero dei voti del falso plebiscito, come dire una carneficina infinita, soprattutto nelle regioni piú toste e piú esposte al vento del nord, cioè negli Abruzzi e nel Molise, ancora oggi poco popolate. Mali antichi che reclamano vendetta al cospetto di Dio. Altro non poteva venire da barbari abituati da secoli a sbranare anche se stessi, come insegna la vicenda valdese. Stirpe di barbari, stirpe di assassini. Ecco l’immagine meravigliosa di sé lasciataci in eredità dai cosiddetti fratelli del nord!
RITARDI STRATEGICI NAPOLITANI
A Rocca Raso i due corpi d’armata si riunirono, quindi marciarono per la strada consolare Castel di Sangro - Isernia. I comandi Napolitani, una volta conosciuto il tradimento del de Benedictis, avrebbero dovuto fin dal 15 settembre porre immediato riparo all’invasione, essere nelle contromisure piú veloci del fulmine. Ma i vertici militari non furono all’altezza dell’emergenza. Quando Ritucci decise di inviare un corpo di spedizione al passo del Macerone, per proteggere il fianco sinistro dell’armata attestata sul Volturno, era ormai troppo tardi.
Nebbia alla valle e nebbia alla montagna, recita uno struggente canto d’amore popolare abruzzese. Quel giorno, 20 ottobre 1860, di nebbia ce n’era tanta, forse non era neppure nebbia, forse erano nuvole che si precipitavano verso il fondovalle, come usualmente avviene nei luoghi alti degli Abruzzi e del Molise, quando i venti umidi e grevi spirano da nord-est. Tutto il verde territorio da Rionero Sannitico al passo della Vandra presso il Macerone, chiave strategica della valle del Volturno, in territorio molisano, all’alba di quel giorno era comunque avvolto in un manto lattiginoso molto spesso. Un distaccamento napolitano, comandato dal generale Scotti, era partito da S. Germano (Cassino) per sbarrare il passo al nemico di cui non si conosceva né la consistenza, né la posizione.
Le forze napolitane non superavano le 2.500 unità, cioè due battaglioni del 1° reggimento di linea e circa 900 gendarmi (A.S.N., Carte borboniche: Sezione Guerra e Marina, busta 1619 in A. Procacci). Tali forze erano coadiuvate da circa 300 volontari. Secondo il colonnello C. Cesari (L’Assedio di Gaeta), che verosimilmente non aveva consultato le carte borboniche, le forze napolitane sarebbero ammontate invece a 5.700 uomini con 4 pezzi di artiglieria; secondo G. Pellicciotti (Avvenimenti politici del 1860 in Chieti, Napoli, 1936, citato dal Procacci), 6.000. In questa babele di numeri conviene attenerci alle carte ufficiali borboniche. Se gli storici non si mettono d’accordo neppure sui numeri, figuriamoci che cosa deve essere per gli altri contenuti. L’avanguardia del IV corpo d’armata nemico, circa 5.000 uomini comandati dal Griffini, la sera del 19 ottobre 1860, aveva intanto occupato il cacúme del monte Macerone.
LE FORZE NEMICHE
L’esatta consistenza e il movimento dei reparti che componevano l’avanguardia nemica si ricava dai diari del IV corpo d’armata relativi ai giorni 12, 18 e 19 di ottobre che riportiamo per amore di completezza:
"12.10 (giorno dell’inizio dell’invasione, ndr) - Diario IV C.A.: Sereno. Alle ore 7 antimeridiane la 4ª Divisione riprende la marcia e va a far notte sotto Giulianova. La 7ª Divisione va ad accamparsi sotto Tortoreto. Il 6° e 7° Btg. Bersaglieri, una Sezione di Artiglieria della 4ª Divisione, la 6ª e 8ª Compagnia del Genio ed i due Reggimenti Lancieri, che debbono formare l’avanguardia sotto gli ordini del gen. Griffini vanno ad accamparsi presso il fiume Tordino. Il Quartier Generale del Corpo d’Armata è a Giulianova.
18.10 - Diario IV C.A.: Sereno. L’Avanguardia da Palena va a far tappa presso Roccaraso. La 4ª Divisione da Lama va ad accamparsi sotto Rivisondoli; la 7ª da Casoli a Palena. Il Quartier Generale è a Roccaraso. L’Avanguardia viene aumentata di una Sezione rigata della 4ª Divisione. Giunge notizia di una colonna di garibaldini disfatta dai Borbonici a Pettorano, poche miglia da Isernia.
19.10 - Diario IV C.A.: L’Avanguardia parte da Roccaraso e fa notte presso il fiume Vandra; due compagnie di bersaglieri prendono posizione sul Monte Macerone in avamposto. La IVª Divisione parte da Rivisondoli per il "Grand Alte" a Casteldisangro e va ad accamparsi a Rionero, una Brigata oltre il Villaggio, l’altra dietro il medesmo. La 7ª Divisione da Palena, si reca a far notte con una Brigata sotto Rivisondoli, coll’altra presso Roccaraso. Il Quartier Generale è a Rionero".
LA BATTAGLIA
Lo scontro avvenne, dunque, all’alba del 20 ottobre. Vediamo come viene descritto dalle due parti in lotta.
"20.10 - Diario IV C. A.: Le truppe borboniche divise in tre colonne, partite il mattino da Isernia attaccano i nostri avamposti sul Monte Macerone. Il generale Griffini fa avanzare i battaglioni bersaglieri e 4 pezzi d’artiglieria per la difesa della posizione. Il generale comandante il Corpo d’Armata giunge poco dopo nel sito alla testa della Brigata "Regina" ed ordina di prendere vivamente l’offensiva. Un battaglione del 9° è ispedito sulla sinistra e con una brillante carica mette in fuga il nemico, in pari tempo il 7° bersaglieri al centro ed il 6° bersaglieri sulla destra caricano e mettono in fuga i Borbonici; uno squadrone di Lancieri di Novara carica ed insegue il nemico sulla strada facendo molti prigionieri. Rimasero nelle mani il generale Scotti, due colonnelli, 35 uffiziali e 700 soldati, la Bandiera del 1° Reggimento di Linea "Re", e due pezzi d’artiglieria. Il 7° battaglione bersaglieri si spinge fino al Volturno e prende posizione oltre il Ponte. Le altre truppe dell’Avanguardia si accampano presso Isernia. La 4ª Divisione dietro la città ad eccezione del 10° reggimento che con due pezzi rigati ed uno squadrone dei Lancieri di Novara prende posizione a due miglia da Isernia a cavallo della strada che tende a Venafro. La 7ª Divisione da Rivisondoli e Rocca raso va a far notte a Rionero; il Quartier Generale è a Isernia".
Secondo lo storico napoletano De Sivo, la battaglia, decisiva per la futura condotta della guerra, si svolse nel modo seguente:
"... Lo Scotti ebbe a sera del 19 notizia di grosse colonne di truppe regolari accampate nella valle Vandra, di là dal Macerone; però parecchi, asseverando fossero Piemontesi, istigavano lo Scotti a occupare la sera stessa la forte posizione del Macerone, dove si poteva contrastare il passo; ma egli, duro, si stette, e lasciò il nemico v’arrivasse primo. Al mattino gli giunse da Teano il 1° di Linea minorato di due compagnie, ch’erano ad Itri; che s’era ricomposto a Capua in 800 uomini col maggiore Auriemma; corpo certamente fievole di coesione, dopo tante peripezie. Adunque con questi stanchi del cammino, con poche centinaia di gendarmi, certi volontari e due pezzi da montagna, lo Scotti il mattino del 20 mosse incontro a tutta l’oste Sarda. I Piemontesi procedevano a grosse colonne l’una sull’altre insieme a pochi faziosi che raggranellavano tra via; guidava l’avanguardia il generale Griffini con due battaglioni bersaglieri e due cannoni della 4ª Divisione. Presso al Macerone, lasciata la strada si gittò sull’alture, e vi si postò, mandando i faziosi avanti a insultare i Borboniani. Lo Scotti al veder questi divise i suoi in tre, sulla strada e su’ lati alle montagne, e gridò: "Date la caccia a quei mascalzoni". Infatti furono respinti fino alla vetta: ma là i Napolitani si sentirono improvvisamente colti da scaglie non viste, eppure procedendo baldi, già due compagnie eran per pigliare i due abbandonati cannoni, quando sbucando di dietro al monte il 3° d’infanteria sarda, perduti alquanti uomini, ebbero a piegare. In quella giungeva il Cialdini con la brigata "Regina", che sulla via maestra corse alla carica. Questi resistettero mezz’ora; morí il Tenente Mattiello, fu ferito il tenente Giordano; ma visto aver da fare con un esercito, prima i volontari e i gendarmi s’allontanarono, percorsi dal 7° bersaglieri, e da uno squadrone di Lancieri; e poi il resto del 1° di Linea rimasto solo e circuito, e per istanchezza del cammino fatto da Teano inabile a’ movimenti, ordinando lo Scotti, pose giú l’arme. Tutti gli altri se la svignarono pe’ monti a Venafro" che il turpe Cialdini voleva poi cancellare dalla carta geografica.
BANDI DI FUCILAZIONE
Era infatti iniziato il Dies Irae, il Dies Irae luciferino con i famigerati bandi di fucilazione: " ... fucilo tutti i paesani che prendo armati e dò quartiere soltanto alle truppe regolari". E lo stragista mantenne la parola. L’altro sanguinario fucilomaniaco, il generale Manfredo Fanti, caporione del corpo di spedizione, vista la mala accoglienza tributatagli dalla città di Isernia, eroica, ferocissima, muta, ostilissima, emanò il primo bando ufficiale per la repressione delle insorgenze che gli invasori chiamarono brigantaggio. Eccolo: "Gli atti nefandi che si vanno commettendo in alcuni paesi da bande armate a brigantaggio, vogliono essere prontamente repressi. S.M il re Vittorio Emanuele, nell’intento di ristabilire l’ordine, di tutelare l’onore, la vita e le sostanze degli abitanti, e di pacificare il paese, ha ordinato che sieno sottoposti e giudicati dai Tribunali militari straordinari, convocati all’Armata a termini del codice penale militare:1) I prevenuti d’atti di brigantaggio, di saccheggio, d’incendi, di ferimenti e di uccisioni. - 2) Tutti coloro che non appartenendo all’esercito regolare del Governo di Gaeta, oppongono resistenza alle Truppe di S.M. o si mantengono mano armata contro l’istituzione della Guardia Nazionale approvata dalle autorità legalmente costituite. - D’ordine di S.M. il generale d’armata Capo di Stato Maggiore: M. Fanti".
Come biglietto di visita, mica male. Ma questo non era né il primo, né l’ultimo. Il sanguinario boia Pinelli, comandante della brigata "Bologna", l’aveva fregato sul tempo col famigerato e demenziale proclama: " ... siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali la pietà è delitto ... annienteremo ... purificheremo col ferro e col fuoco ...". La saharizzazione delle Due Sicilie era cominciata.
GLI OMICIATTOLI NOSTRANI
A cotali proclami si aggiungevano quelli del servitorume filosabaudo. Il nuovo governatore della provincia di Teramo, il rinnegato De Virgili, scimmiotta il Fanti con un proclama ancora piú lercio e demenziale, datato due novembre, di cui riportiamo i passi piú significativi: "4°) Gli attruppamenti saran dispersi con la forza. I reazionari, presi colle armi alla mano, saran fucilati. Gli illusi e i sedotti che al giungere delle forze nazionali (cioè i tartari piemontesi, ndr) depositeranno le armi, e si renderanno (cioè si arrenderanno, ndr), avran grazia. Ai capi promotori non si accorderà quartiere, purché non si rendessero a discrezione e senza la minima resistenza; nel qual caso avran salva la vita, e saranno rimessi al potere militare. - 5°) Gli spargitori di voci allarmanti, che direttamente o indirettamente fomentano il disordine e l’anarchia, saran considerati come reazionari, arrestati e puniti militarmente, e con rito sommario (Archivio storico di Teramo: Giornale Intendenza Abruzzo Ultra 1°, anno 1860, in A. Procacci, ibidem)".
Il 9 novembre altro proclama di morte: "AVVISO - Il ten.col. A. Curci, comandante la legione Sannita, dichiara a tutti gli abitanti de’ dintorni di Civitella vietata ogni comunicazione con quella Piazza e punita, in caso di contravvenzione, irremissibilmente con la morte. - Dal quartier generale di Faraone: 9 novembre 1860".
Ma il Curci, nonostante le minacce, cominciò lui a tremare, come si può capire leggendo tra le righe il rapporto al generale Fanti da parte del traditore Veltri: "Il Ten. Col. Curci comandante della Legione Volontari Sanniti del blocco della Piazza di Civitella mi rapporta che ieri mattina verso le 8 ant. una massa imponente di briganti, scendendo dalla montagna, lo assalí a colpi di moschetto, e siccome erano disposti in diversi punti, egli prese tutte le misure possibili, non solo per tenergli in iscacco, ma per respingerli. Infatti, dopo un fuoco vivissimo, sostenuto per circa due ore, riuscí a metterli in fuga, rintanandosi tra i monti. Mi soggiunse inoltre che con lo strapazzo continuo, le veglie, escursioni notturne, assalti di briganti, e numerosi punti a guarnire per custodire il blocco, ridurranno ben presto quelle poche forze a nullità ..." (Riportato in A. Procacci, ibidem).
IL DOLORE DI ALIANELLO
Il commento piú doloroso e pertinente a tali mostruose sanguinarie abiezioni dei biechi assassini savoiardo-piemontesi, ci sembra una pagina di Alianello (La conquista del Sud): "Basta, l’anima nostra e la nostra pazienza ripugnano al triste rosario di violenze, di proibizioni, d’orrori. Masserie chiuse o distrutte, bestiame massacrato, fienili, pagliaia, uomini, sí, anche uomini, dati alle fiamme, arrestati, fucilati ... Le tristi strofe si ripetono una dopo l’altra, inesorabili, monotone, sanguinanti, mostruose. Sarà arrestato, sarà fucilato, fucilato, fucilato ... Né si può dire che gli arrestati stessero molto meglio di quelli che, con quattro pallottole nella schiena, venivano gettati nei burroni, nei letamai, in pasto alle volpi, ai lupi, ai cani ... "
"Al mio Popolo non lasceranno neppure gli occhi per piangere": parole profetiche di Francesco II, nostro primo concittadino, nel mettere piede sulla lancia che lo avrebbe portato in doloroso struggente esilio (Io - chi leggendo il proclama dell’8 dicembre 1860 non prova dolore per siffatto lacerante grido? - sono Napolitano, nato tra Voi, non ho respirato un’altra aria, non ho visto altri paesi, non conosco altro suolo che il suolo natale. Tutte le mie affezioni sono nel Regno; i vostri costumi sono i miei costumi, la vostra lingua è la mia lingua, le vostre ambizioni sono le mie ambizioni).
ANCORA LA BATTAGLIA
Il miglior resoconto circa la condotta del generale Scotti al Macerone rimane tuttavia quello del cappellano don Giuseppe Buttà (Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta), eroico comprimario nella difesa di Gaeta:
"Trovavasi in S. Germano (Cassino, allora enclave pontificia, ndr) il generale Scotti, con un’alta missione politica e finanziaria; egli si avvicinò ad Isernia. Aveva sotto il suo comando poca gente, cioè 240 volontari e pochi gendarmi, capitanati dal tenente colonnello Achille de Liguori; questa poca forza gli era stata data per proteggere le popolazioni dalle intemperanze e soprusi de’ rivoluzionari contro quei paesi da costoro invasi. Scotti non volle credere agli avvisi di de Liguori; il quale avevagli fatto conoscere che alla Vandra era giunto un Corpo di esercito piemontese. A questo avviso avrebbe dovuto correre per occupare la forte posizione del Macerone, dove con poca gente si poteva tenere a segno numeroso nemico, e darne conoscenza al generale in capo Ritucci. Scotti, poco curandosi di tutte le notizie che riceveva conformi a quanto avevagli detto de Liguori, rimase inoperoso, supponendole false, o che aveva da fare con masse armate solamente. Nondimeno prese una determinazione che è inesplicabile, cioè a dire, si recò a Venafro ov’era altra truppa per condurla ad Isernia. Si trovava in quel paese un pelottone (cioè un plotone, ndr) di cacciatori a cavallo, comandato dal 1° tenente Paolo Vincenzo Santacroce, due cannoni guidati dall’aiutante de Felice, e dieci compagnie del 1° di linea (l’altre due erano ad Itri) comandate dal tenente colonnello Gioacchino Auriemma, uffiziale che si era ben distinto nel 1849 sotto Satriano alla riconquista della Sicilia, ed in varii fatti d’armi nel 1860. Auriemma ligio alla disciplina militare non voleva marciare per Isernia senza l’ordine del Generale in Capo, ma Scotti l’obbligò facendo uso di quella facoltà che avea di Commissario straordinario con l’alter-ego. Scotti la mattina del 20 ottobre, diede l’ordine a tutta la sua gente di salire sulla montagna del Macerone ed attaccar zuffa co’ supposti rivoluzionari. In quella sopraggiunsero tre villici tutti affannosi, e dissero al tenente Santacroce che sul Macerone era accampata molta truppa estera. Scotti, avvisato, tuttavia non volle crederlo, anzi sgridò molto il Santacroce, e gli diede del ciarlone; costui era andato alla scoperta, ed assicurava che sul Macerone vi fossero soldati piemontesi. Quel Generale aveva proprio la mania dell’incredulità e di condurre i suoi soldati al macello: fece arrestare i tre villici come spargitori di notizie false, ed ordinò a tutti i suoi dipendenti di assalire i supposti rivoluzionari sul Macerone: egli però rimase aspettando sulla via consolare. Quella poca truppa fu divisa in tre piccole colonne e marciò all’assalto del nemico; il quale trovavasi sopra una posizione inespugnabile. Sul Macerone realmente era giunta una parte dell’esercito piemontese, cioè ottomila uomini con artiglieria e cavalleria, e procedevano a grosse colonne. Comandava l’avanguardia il generale Griffini con due battaglioni di bersaglieri e due cannoni rigati. Costui, appena vide la poca truppa napolitana che si avanzava, mandò incontro una squadra di rivoluzionari per insultarla, ma costoro furono ben picchiati ed inseguiti dai soldati borbonici. Giunti i Napoletani a tiro, furono assaliti da tutta l’oste sarda. Cialdini con la brigata "Regina" dalla via maestra, corse alla carica, e prolungava le ale del suo esercito per avviluppare i borbonici. Costoro si difesero da valorosi in quello scontro ove combattevano uno contro dieci e con lo svantaggio della posizione e della sorpresa. Si distinse piú di tutti per bravura ed accorgimento il tenente colonnello Auriemma, che dirigeva quello assalto; si distinsero pure i due maggiori del 1° di linea Ciccarelli e Pellegrino, il capo pelottone de’ Cacciatori a cavallo Santacroce, l’aiutante di artiglieria de Felice, non che il tenente colonnello de Liguori, che comandava i gendarmi. Però essendo pochi di numero, ripiegarono inseguiti da’ lancieri di Novara, comandati dal capitano Coccolito-Mondio. Furono feriti in quell’incontro i tenenti Antignano e Giordano. Rimasero prigionieri 400 soldati del 1° di linea, ed il comandante Auriemma. I lancieri di Novara, caricando i Napoletani, che ancora erano sulla via consolare, fecero prigioniero il generale Scotti; mentre gli altri presero la via di Venafro. Con lo Scotti furono fatti prigionieri il colonnello Gagliardi dello Stato Maggiore, il tenente colonnello de Liguori, tre uffiziali di gendarmeria, 125 gendarmi e i due cappellani del 1° di linea D. Francesco Mirone e D. Oronzo Lagatta, tutti e due feriti, uno al braccio e l’altro alla testa, da un lanciere di Novara. Dei cacciatori a cavallo rimase prigioniero il 1° tenente Santacroce ... il resto dei soldati Napoletani si ritirò per i monti di Venafro, e raggiunse il grosso dell’esercito in Teano".
Il generale Scotti fu poi inviato prigioniero a Torino. In una nota a pie’ di pagina il Buttà conchiude: "Quattro storici contemporanei, cioè Delli Franci, Cava, tutti due dello Stato Maggiore, de Sivo e Farnerari dicono parole amare contro il generale Scotti, per il modo come si comportò prima e dopo la di lui prigionia".

Frattanto il Ministro degli Esteri di Francesco II, Casella, inviava una protesta al Corpo Diplomatico residente in Gaeta: "... Mentre Re Francesco lascia la vita a’ volontari stranieri ed a’ suoi ribelli, diventati garibaldini, generali sardi mettono a morte i sudditi fedeli del legittimo Sovrano, combattenti per la Patria ..." e Francesco II a sua volta, fece pervenire un accorato appello ai sovrani d’Europa, divenuti sordi ad ogni convenienza politica. Austria e Russia, potenze conservatrici e alleati naturali del Regno, avrebbero pagato successivamente in modo amaro la loro fellonia e cecità: " ... Per sí turpi atti forse i regi soldati saranno schiacciati, e soccomberà l’indipendenza e l’antica Monarchia di questo paese, ma soccomberanno pure tutti i diritti, i principii e le leggi su cui la sicurtà delle nazioni riposa. Le Sicilie cadute saranno prova al mondo ch’è lecito calpestare la lealtà e la giustizia ... i diritti, i trattati, spregiando le umane leggi, e sfidando l’opinione dell’Europa civile".
CONSEGUENZE DEL MACERONE
Dopo il Macerone, nei giorni 21 e 22 ottobre, l’esercito sgombrò la linea del Volturno e iniziò la ritirata oltre il Garigliano. Furono molti i fatte d’arme in cui rifulse il valore dei nostri soldati. Ma ormai l’esercito era accerchiato e la sua prossima fine era nell’aria. Gaeta fu l’estrema difesa della Monarchia e del Regno. A questa seguí una dittatura ferocissima, sanguinaria, di cui non è dato trovar simili negli annali delle storie. Neppure in questo secolo di mostri.
Il 2 novembre 1860 cadde la piazza di Capua. Fuori le mura, a godersi lo spettacolo della resa, c’era quella vermona vestale del cinismo e del tradimento, di nome de Benedictis, insieme ad altri carognoni generali vendutisi al nemico, tutti degni d’ ‘a forca ‘e masto Donato: Adraga, Zaini, Jovine, Ferrarelli, Locascio, Cosentino "tutti beneficati, o mantenuti gratis da’ Borboni nei collegi militari ... I soldati capitolati di Capua entrarono in Napoli il 4 novembre, e furono vilipesi e insultati dai camorristi; poi furono mandati a Genova ..." (Don Giuseppe Buttà, ibidem).
Vadano ai valorosi e fedeli soldati delle Due Sicilie e a tutti i martiri della feroce invasione le benedizioni della nostra Patria derelitta, con la speranza che il Divino Artefice e Sommo Reggitore dell’Universo li abbia felicemente accolti nel Suo infinito seno. Amen.
RIN
Preghiera di Francesco II (diario, 31 dicembre 1867):
"Metto nelle mani del Signore la causa del mio trambasciato (afflittissimo, N.d.R.) paese".
![]()
LARGO ‘E PALAZZO
Chi ha avuto, ha avuto
e chi ha dato, ha dato,
(ma nun) scurdammoce ‘o passato:
simme ‘e Napule, paisà !
Gennaro - neh, Vicie’, diceno a Napule: ccà nisciuno è fesso, ma io stong’ a penza’ ca nunn’è overo. Chiste nce fanno fesse comme e quanno vonno lloro. Accumenciano a quann’jamme a scola a nce fa mparà ‘e strunzate d’ ‘o risorgimento, e chillu sament’ ‘e Galibardo e cumpagnia cantante! (Ciao Vincenzo, dicono che a Napoli nessuno è fesso, ma io credo che non sia cosí, perché ci prendono in giro come e quando vogliono. Incominciano già a scuola a farci studiare sempre le solite menzogne sul risorgimento e Garibaldi)
Vicienzo - e vabbuò, ma tu ‘o ssai ca a Napule e chesti cose nun ce ne futtimme propeto. ‘O napulitano verace ‘o capisce subbeto, appena nasce, ca d’ ‘o guvierno taliano nun s’adda mai aspettà niente, pecché chille è stato sempe cuntr’a nuje, e sempe cu chilli tradeture leccaculi d’ ‘e pulitici nuoste. Tante pe te fa n’esempio, D’Alema ha fatto nu decreto p’abolí l’Enel, p’ ‘o fa privatizzà, e ha smobilitato nu sacco ‘e servizi ca tene a Napule e a Palermo. Sai chesto che significa? ca ‘a currente, nuje d’ ‘o Sud, ‘a jamm’ a pavà cchiú assaie e, aroppo, datosi ch’ ‘a produzione d’ ‘a currente a du nuje è ‘o 20 % d’ ‘o totale, nuje dipennimmo - p’avé ‘a currente - praticamente d’ ‘o Nord e nun putimme manc’ arapí na fabbreca nosta o fa nu pruggetto ‘ngrazie ‘e Ddio. (Va bene, ma tu lo sai che a Napoli queste scemenze non ci interessano. Il vero Napoletano sa già fin dalla nascita che il governo italiano è sempre contro il Sud, soprattutto a causa di quei politicanti meridionali, traditori e servi del Nord. Tanto per fare un esempio recente, D’Alema ha fatto un decreto per abolire l’Enel come Ente pubblico e ha fatto smobilitare tutti i relativi servizi tra Napoli e Palermo. Questo significa che ci sarà un forte aumento dell’energia elettrica ed, inoltre, dato che quasi l’80% della produzione di elettricità è al Centro-Nord, noi del Sud saremo totalmente dipendenti da nuovi padroni privati e non avremo nemmeno la possibilità di fare un qualsiasi nostro progetto imprenditoriale tranquillamente).
Gennaro - Chilli fetiente ‘e stúriene ‘e tutt’ ‘e manere pe’ bberè comme nce hanna sfruttà! Però mo’ D’Alema ha ditto ca fa ll’Agen Sud e nce mett’a posto a tuttu quante. (Quei vigliacchi le studiano tutte per sfruttarci come una colonia. Però ho sentito che D’Alema ha un progetto di una Agenzia per il Sud, per cui dovremmo risolvere i nostri problemi.)
Vicienzo - Bbuono chille! Ha ditto ca tene ciento idee pe’ spennere int’ ‘o Sud centoventimila miliardi a tutt’ ‘o 2006. Si vene a Napule nce appicciame ‘e carte arreto! A chi vo’ fa fesso: chell’è sulo fummo. ‘Nzomma ha fatto n’ata Cascia d’ ‘o Miezujuorno pe’ fa ‘e solite cose: zucà vote pe’ ogn’elezione e pe’ dà a magnà a chilli magnasive d’ ‘o Nord, c’accussí finanziano annascoste pur’ ‘e partiti. (Buono quello! Ha affermato che ha cento idee per poter spendere 120.000 miliardi fino al 2006, ma è solo fumo e a Napoli lo considerano niente. Quello vuole fare un’altra cassa del mezzogiorno con la quale prendere voti per ogni occasione elettorale e dare altri guadagni a quelli del Nord, che cosí poi ti rifinanziano sottobanco i partiti)
Gennaro - Però quacche cosa se move pur’a du nuje, comme ‘o puorto ‘e Gioia Tauro ca sta jenno forte assaie. (Però da noi incomincia a muoversi qualcosa. Il porto di Gioia Tauro ha centuplicato il suo movimento)
Vicienzo - Gennarí, ma tu quann'è ca te scite? ‘O stanno facenne sviluppà pecché se vere c’addà serví a coccheruno, comm’hanno fatto cu chill’ ‘e Bari, ca po’ so’ song’ accattato ‘e furastieri. E po’? Nu puorto, pe’ gghi bbuono, nunn’ha da tene’ sul’ ‘a posizione, ma ha da tene’ nfrastrutture e servizi ca funzionano, asinò chi nce va? E te pare ca nuje tenimme strade e ferrovie ‘e chell’altezza? Tu nun ti ‘a lusingà propeto. Pe’ capí addò ce fottono va a smiccià ‘e contribbuti c’ ha dato ‘o Stato p’ ‘e puorti ‘taliani: p’ ‘o Nord 118,2 miliardi, ment’ ‘o Sud n’ ha avuto sulo 54,9. Ca po’ a du nuje si arrive caccosa è sule pe’ ll’amici ‘e ll’amici .(Gennarino, ma quando ti svegli? Per ora lo lasciano sviluppare perché si vede che hanno un piano da sfruttare, come hanno fatto con il porto di Bari che poi è stato venduto a stranieri. Infatti, se rifletti un poco, un porto per andare bene deve avere non solo una valida posizione geografica, ma anche infrastrutture e servizi molto efficienti. Da noi tutto questo non c’è ed è quindi prevedibile che ci sia in previsione qualche losco affare nel futuro. Per capire tutto questo basta considerare che nel Nord hanno speso recentemente per i porti e interporti 118,2 miliardi, mentre al Sud ne sono arrivati solo 54,9. Che spesso, questi soldi quando arrivano, sono per gli "amici degli amici").
![]()
Lu Spingulu te Lecce
ARCU TE PRATU
... ma va a fa ...
Si ricomincia. Buon Appetito!
Non spingete, c’è posto per tutti. Buon appetito e usate le posate, eviterete di sporcarvi le mani. Snelli rimarranno i disoccupati del Sud.
Non abbiamo letto Romano, nessuna intenzione di leggere Talamo, ma siamo certi che un milione di morti ammazzati e milioni di emigranti del Regno delle Due Sicilie, se potessero, ringrazierebbero di cuore.
©
Ronzu: Tocca ‘me scusi, ma cce bbete sta "agenzia pe llu Sud? (Scusa, ma che cosa è questa Agenzia per il Sud?)
Pici: Bah, quasi quasi ete la copia de la cascia pe lu mezzogiornu (Beh, piú o meno è la copia della cassa per il mezzogiorno)
Ronzu: Aggiu capitu! Sordi menati allu ientu! E nienti fatia. (Ho capito! soldi buttati al vento! E niente lavoro)
Pici: Mena moi! Comu si pessimista! Comu l’autra fiata li pulitici e li caloppini loru tenunu de buscare. Pe’ la fatia poi, nu t’ha percocare! sta aggenzia pe’ lu Sud nde face nascere tanta de fatia, ma propriu tanta ... a llu Nord. (Su dai! Come sei pessimista! come l’altra volta politici e galoppini guadagneranno. Per il lavoro non ti preoccupare! Ne nascerà tanto, ma tanto ... al Nord)
Ronzu: Aggiu capitu ... fazza Ddiu ... cia’ facimuni mienzu quintu ca è megghiu (Ho capito ... Faccia Dio ... Andiamo a farci un bicchiere che è meglio.)
(St. Oronzo Circus, december 10, ‘98, afternoon)
![]()
La Sicilia nel Vento del Sud
Amara e bellissima la Sicilia degli anni che vanno dal 1943 al 1946: vi aleggiava, palpabile, un insostenibile sogno, quello di essere Nazione finalmente padrona dei propri destini. Certo su quel sogno e sugli entusiasmi sinceri che coagulò si può non essere d’accordo, ritenerlo pura utopia e disquisire con filosofica sottigliezza, sull’esistenza o meno di una Nazione Siciliana, ma una cosa non si può negare che la stragrande maggioranza dei Siciliani sperò ardentemente che esso si realizzasse ed agí ed operò attivamente, almeno in un certo periodo, di conseguenza.
Ai soliti saccenti del suo partito sempre in ritardo nel capire le ragioni del Sud, Palmiro Togliatti fu costretto a ricordare, per evitare pericolosi abbagli, che il fenomeno separatista non poteva spiegarsi soltanto con le mene dei reazionari o dei servizi segreti stranieri, ma che esso era qualcosa di piú grande. Era uno stato d’animo generale di ribellione di tutto un popolo, il Siciliano, contro uno Stato centralista, visto come un nemico da abbattere.
La Sicilia ai Siciliani non fu, quindi, soltanto uno slogan, ma qualcosa di molto, ma molto piú complesso. La mai sopita voglia d’indipendenza e di autonomia, malgrado secolari repressioni, risorgeva ora piú forte che mai. I Siciliani riscoprivano vecchi simboli e vecchie bandiere. Le loro bandiere. Come quella a strisce gialle e rosse, orgogliosamente sventolata dinanzi al mondo intero per rivendicare la propria peculiare specificità. Con quei colori garrivano al vento oltre settecento anni di Storia Siciliana. Essa già sventolava al tempo dei Vespri, quando la collera popolare atterrò d’un colpo solo la tracotanza dell’occupante francese. Vecchia bandiera contrapposta alla nuova, quella tricolore, mai troppo amata.
Forse ai Siciliani bruciava ancora l’ottuso ed ingeneroso giudizio di un famoso generale italiano, che, nel ‘17, aveva definito la loro isola "covo pericoloso di renitenti e disertori". Ed invece erano stati loro ad essere traditi, fin dal giorno dopo l’entrata di Garibaldi a Palermo. Da allora considerati sempre e soltanto carne da macello, e guai a ribellarsi. Ecco perché ora all’estraneo scudo crociato sabaudo anteponevano il misterico simbolismo della Trinacria, l’enigmatico volto femminile con le tre gambe, che richiamavano i tre promontori della Sicilia classica. Quasi a voler ribadire che loro, rispetto agli altri, avevano radici e civiltà assai piú antiche.
E i Siciliani si accorsero d’un tratto, con stupore, che quelle bandiere, quei simboli, quelle parole d’ordine li affratellavano, li facevano sentire veramente Nazione, facendo dimenticare feroci e secolari rivalità cittadine.
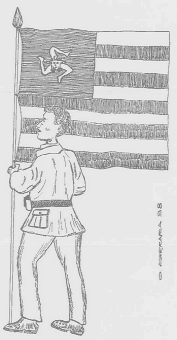
D’altronde il Movimento fu anche capace di dotarsi, al momento necessario, di un proprio braccio armato, l’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza Siciliana). Che la lotta politica si sia alla fine trasformata in lotta armata, vista la posta in palio (l’Indipendenza), era forse inevitabile. Anche perché furono in molti, e non soltanto i separatisti piú estremisti, a spingere in questa direzione. E cosí la Sicilia, per circa tre anni, divenne l’Irlanda italiana. Stesso stillicidio di morti, stesso odio irriducibile tra le parti contendenti.
A far sí che il bel sogno divenisse un cosí orrido incubo, contribuirono un po’ tutti. Dagli irriducibili del separatismo, convinti di bruciare in questo modo i ponti alle spalle dei tiepidi della loro parte e degli autonomisti, e farli cosí confluire su posizioni piú radicali; ai "proconsoli", inviati in Sicilia dal governo italiano, che vietarono scioccamente qualsiasi manifestazione, anche la piú innocua di sicilianità, spingendo infine con una brutale repressione poliziesca alla ribellione generalizzata, a questa poi rispondendo con ulteriore repressione e cosí di seguito, in una spirale crescente di violenza verso la guerra civile. Dal servizio segreto americano che, vincolato agli accordi di spartizione con i Russi, cercò di screditare e macchiare la causa separatista, foraggiando e gonfiando oltremodo quel velleitario movimento della Sicilia quale Quarantanovesima Stella degli Stati Uniti; ai servizi segreti britannici, che cercarono di perseguire il vecchio disegno inglese di creare nel Mediterraneo tutta una serie di isole indipendenti (Sicilia, Pantelleria e, forse, la Sardegna) da attrarre, tramite Malta, nella loro sfera d’influenza.
A riguardo di queste macchinose mene dei servizi segreti degli Alleati, si deve alle indubbie capacità di Finocchiaro Aprile, leader indiscusso di tutti i separatisti, se le stesse furono spesso, con strategie oculatamente differenziate, rese inoffensive o addirittura strumentalizzate ai fini del Movimento Separatista.
Altro che marionette manovrate dai servizi stranieri, come ha scritto qualche storico superficiale. Anche certa destra contribuí a far precipitare la situazione. Accecata da un becero nazionalismo ottocentesco, fu "magna pars", almeno nelle città, nelle provocazioni e nelle aggressioni dei separatisti, soprattutto giovani studenti, non sospettando minimamente di fornire i pretoriani e i mazzieri per i nuovi padroni del vapore, che incombevano all’orizzonte, i democristiani. Storia che per il Meridione si ripeterà, nei decenni a venire, purtroppo molte altre volte.
Non da meno fu una certa sinistra, che, seppure supportata da una vivace intellighenzia, non seppe far di meglio che rinchiudersi nel ghetto angusto delimitato dalle direttive del partito egemone, il partito comunista. Anzi non poche volte essa fu piú realista del re, sollecitando una repressione ancora piú dura. Anche questo sarà un cliché che si ripeterà piú volte nella tormentata storia meridionale del dopoguerra.
E veniamo ai tanto strombazzati "oscuri" intrecci tra Separatismo, Banditismo e Mafia, che hanno fatto versare fiumi d’inchiostro a sproposito alla parte meno attenta della storiografia nostrana.
Nella Sicilia di quegli anni qualunque movimento politico di massa doveva, volente o nolente, fare i conti con il banditismo endemico e con l’onnipresente Mafia. Con il banditismo, fin quando la lotta fu circoscritta alle città ed ai grossi centri, all’inizio fu facile; ma quando con la morte di Antonio Canepa, il carismatico Comandante in Capo dell’EVIS, ucciso il 17 giugno 1945 in circostanze misteriose (ferito, lo si lasciò per ore senza soccorsi, facendolo morire dissanguato), fu giocoforza per i combattenti separatisti darsi alla macchia e salire sulle montagne, si presentò subito il problema della difficile convivenza con le bande che infestavano quei luoghi. A questo momento si fa risalire la nuova strategia dell’EVIS, guidato ora da Concetto Gallo, di guadagnare tali bande alla causa indipendentista. Come d’altronde aveva già fatto Garibaldi nel 1860.
Nell’agosto del 1945, con l’accordo detto di Ponte Sagana, le bande della Sicilia occidentale capeggiate da Salvatore Giuliano, nominato per l’occasione colonnello dell’EVIS, iniziavano la guerriglia contro le forze governative in nome della Sicilia libera. Guerriglia, che seppur spietata, fu abbastanza leale almeno fino al momento in cui Giuliano fiancheggiò l’EVIS. Poi, qualche tempo dopo la cattura di Concetto Gallo, avvenuta nella battaglia di Piano della Fiera (il canto del cigno del braccio armato separatista), Giuliano riprese la sua libertà d’azione, facendosi però irretire nelle trame della Mafia, con cui si accordò segretamente nel maggio del 1946. Accordo che doveva portarlo alla tragica e fatale giornata di Portella della Ginestra, dove bruciò d’un colpo l’enorme ammirazione popolare, che lo aveva sempre accompagnato.
Con le bande della Sicilia orientale fu tutt’altro discorso. Le piú forti di esse, le temute bande Avila e Rizzo, pur fiancheggiando per un certo periodo l’EVIS, restarono bande dedite prevalentemente al saccheggio, guidate inoltre da capi sanguinari. La loro primitiva tattica di guerriglia non prevedeva di far prigionieri. Questa aberrante logica portò all’eccidio di Feudo Nobile, dove furono fucilati otto carabinieri, che si erano arresi. L’inutile e controproducente strage portò alla rottura con l’EVIS.
Piú complessi i rapporti tra Mafia e Separatismo. Qualunque movimento politico, che abbia operato, operi ed opererà in Sicilia, ha rischiato, rischia e rischierà sempre di avere qualche suo ganglio vitale avviluppato dai sottili, intriganti e lunghi fili, che la Mafia tesse incessantemente per godere delle necessarie coperture. E quella politica è sempre stata ritenuta di vitale importanza, per cui vale la pena, se ne è necessario, uccidere.
Nel 1943 quello che vedono tutti è che la Mafia è in egual misura antifascista ed anticomunista ad un tempo. Essa teme come la peste i regimi totalitari, perché gli stessi implicano sempre un controllo di tipo "militare" del territorio, cosa che inevitabilmente la soffoca. Inoltre, in quei giorni, l’organizzazione mafiosa gode di una sorta di rispettabilità istituzionalizzata per il concreto aiuto prestato, tramite gli stretti collegamenti con i confratelli siculo-americani, allo sbarco delle truppe alleate. Famosa la bandiera di riconoscimento adottata: un quadrato giallo-oro con al centro una L nera. Dove la L stava per Lucky (il boss Lucky Luciano) ed allo stesso tempo per "fortuna" (in americano "lucky").
Le vaste e spontanee adesioni, di cui godé il movimento separatista fin dal primo momento, colsero alla sprovvista i vari capi-mafia. Al massimo le loro simpatie potevano andare, come andavano, al movimento fantoccio filo-americano della "Sicilia 49ª Stella degli Stati Uniti. Illuminante a questo riguardo la lettera aperta in tal senso di Salvatore Giuliano al Presidente Truman nel ‘47, quando, dopo il patto d’intenti dell’anno precedente, piú forte era l’influenza della mafia su Giuliano.
Lascia quindi perplessi la formale adesione, nei momenti iniziali, all’ideologia ed al movimento separatista del capo dei capi, don Calogero Vizzini, malgrado la ferma opposizione di parte dei dirigenti indipendentisti. Eppure don Calogero non poteva ignorare, per i suoi stretti contatti con New York, che gli Americani avrebbero boicottato a tutti i costi la causa del separatismo. Anche la plateale pubblica adesione non rientrava nello stile comportamentale di don Calogero, per il passato sempre accuratamente defilato, come d’altronde si confà ad un vero capo-mafia. Nemmeno l’ipotesi dell’entrata nel Movimento per cercare di condizionarlo e screditarlo non regge; questo compito sarebbe stato affidato ad altri e sotto copertura.
Ed allora? Per tentare di comprendere cosa effettivamente spinse don Calogero Vizzini ad un passo cosí grave è necessario andare al cuore di quel groviglio inestricabile di sentimenti e passioni che è la sicilianità. Fu l’appassionata e disinteressata adesione al separatismo di tanta parte della picciottería isolana a spaventare la Mafia. Per molti di quei picciotti l’affiliazione mafiosa era dovuta soltanto ad un malinteso senso di sicilianità, una sorta di sicilianità deviata. Ed ora quelle nuove parole d’ordine di una Sicilia grande, libera ed indipendente, che affascinavano gran parte di essi. Gente che fino ad allora non aveva mai avuto il senso dello Stato, considerato sempre alla stregua di un usurpatore, sentiva finalmente l’orgoglio di appartenere ad una comunità, quella Siciliana, per cui valeva la pena di vivere ed anche di morire. Se la Mafia era stata la mamma, adesso la Sicilia diventava la Mamma di tutte le mamme, cui tutto si poteva sacrificare. Ed era una passione cosí coinvolgente da trasformare un Giuliano da bandito a guerrigliero della libertà isolana, oppure di spingere delinquenti incalliti a cercare di chiudere in bellezza una vita sbagliata, come il caso della banda La Barbera, i cui componenti, al momento di essere condotti davanti al plotone d’esecuzione, grideranno ai loro carcerieri: "Faremo vedere come sanno morire i Siciliani" e poi, ancora, di fronte alle bocche dei fucili ormai puntati: "Viva la Sicilia, Viva il Separatismo, Viva Finocchiaro Aprile!".
Questo diffuso stato d’animo spaventò la Mafia, il terrore di perdere l’humus in cui affondava storicamente le sue radici. Ed ecco il perché del comportamento di don Calogero, il Padrino dei padrini, quasi a voler dire eccoci qua, ci siamo anche noi, senza di noi non sarebbe stato possibile tutto ciò, anzi prendiamo sotto la nostra protezione il separatismo.
Era un bluff per tenere legata ancora una volta la picciottería, ma il cuore dei capi-cosche stava da tutt’altra parte. Lo si vedrà chiaramente, qualche anno dopo, quando si delineerà la nuova area politica detentrice delle leve del potere in Sicilia. Ad essa la Mafia ha già regalato Portella della Ginestra, di lí a poco l’assassinio dell’ormai ingombrante Giuliano. Le collusioni con apparati deviati dello Stato cominciarono allora.
La Mafia non condizionò mai, né tantomeno tentò di controllare o strumentalizzare, il Movimento Separatista. Non per eccesso di bontà, ma per il fondato timore di trasferire al suo interno dirompenti contraddizioni, che avrebbero finito per minare alle fondamenta la stessa struttura mafiosa. Si limitò ad aspettare che finisse la tempesta. È stata soltanto l’adesione di facciata di Calogero Vizzini a far congetturare ad alcuni storici chissà quali segreti accordi tra la Mafia ed il Separatismo. Niente di piú sbagliato.
La lotta armata, pur se non raggiunse il suo scopo, che era l’indipendenza della Nazione Siciliana, creò le premesse con cui la parte autonomista del Movimento costrinse il governo italiano a trattare paritariamente sulla questione Siciliana, spuntando alla fine uno statuto di ampia autonomia regionale, oltre all’amnistia per i combattenti dell’EVIS. Si deve all’accortezza politica di un De Gasperi, l’aver saputo cogliere al volo (forse anche per le simpatie filo-autonomiste dovute alla sua origine trentina) l’occasione per disinnescare quella vera e propria bomba ad orologeria rappresentata dall’ideologia separatista, che a lungo andare avrebbe finito con lo sfasciare l’Italia intera.
L’autonomia concessa alla Regione Sicilia era sulla carta amplissima e come, amaramente, osservò qualche esponente separatista poteva essere piú che l’indipendenza, soltanto se si avesse avuto piú coraggio da parte degli eletti all’assemblea regionale nel rompere, pur restando unitari, i legami di una sudditanza acritica nei confronti dei poteri romani.
Poteva esserci un formidabile laboratorio politico per il riscatto delle genti del Sud. Ma non fu cosí. Non vi fu alcun laboratorio politico, nessun riscatto e la sudditanza diventò sempre piú servile. E se qualche flebile tentativo si fece nel cercare nuove ed originali soluzioni, come il pur discutibile caso Milazzo, subito abortí a causa dei fulmini di scomunica del centralismo romano.
Si svuotava cosí nei fatti un’autonomia faticosamente conquistata. Cominciava allora l’ingabbiamento di tanti politici nel sistema perverso delle tangentopoli, la cui ragnatela, soltanto ai giorni nostri, è stata in minima parte disvelata.
La Sicilianità riemerse orgogliosamente ancora una volta negli anni Ottanta quando, nell’assemblea regionale, respinse sdegnosamente la proposta di erigere, a Marsala, un monumento al "liberatore" Garibaldi ed ai suoi mille.
Quello che è troppo, è troppo.
Orazio Ferrara
![]()